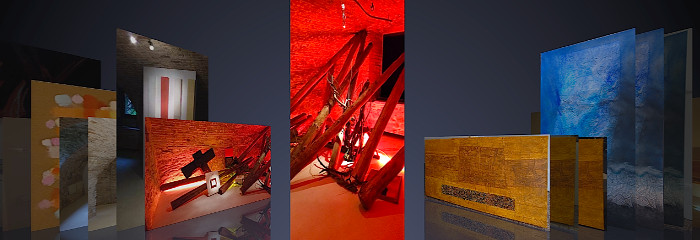Multipersonale d’arte. SOGNARE IL FUTURO, 7-23 ottobre 2022
a cura di Gino Prandina
Salone espositivo dell’Antica Filanda
Mirta Caccaro
Paolo Bortoli
Elia Inderle
Roberto Lanaro
Gino Prandina
Giuseppe Vencato
Via Roma Sovizzo – Con il patrocinio del Comune di Sovizzo (VI)